Programma del Congresso 2024
Ricercatori a livello internazionale, esperti, Veterinari, Etologi e Educatori Cinofili a confronto per un aggiornamento davvero unico nel suo genere
Presiedono all’evento: Eleonora Mentaschi e Luca Spennacchio
Orario: la registrazione e l’accesso dei partecipanti in presenza presso la sala conferenza avverrà dalle 8:00 alle 9:15. L’accesso dei partecipanti in modalità live streaming avverrà dalle 8:00 alle 9:00 del sabato e della domenica. Si avrà inizialmente accesso ad una “stanza di attesa” e la segreteria farà accedere un pò alla volta al congresso. Preghiamo tutti i gentili iscritti di essere puntuali e accedere in tempo utile, considerando il numero di partecipanti all’evento. Ritardatari: dopo le 9:15 non sarà possibile accedere e si dovrà attendere la pausa tra un relatore e il successivo per accedere.
8:00 Apertura segreteria e accesso all’evento
9:30 Inizio conferenza
13:00-14:00 Pausa pranzo
17:30 Chiusura relazioni
A seguire i relatori del congresso, che siamo onorati e orgogliosi di ospitare a questa quarta entusiasmante edizione. L’elenco dei relatori verrà aggiornato con alcune news!
CLICCA PER SAPERNE DI PIU’

Dott.ssa Elisabetta Mariani Biologa, Istruttrice Cinofila, Collabora con l’Università Vita Salute del polo San Raffaele Hospital di Milano, Italia
LA TEORIA POLIVAGALE APPLICATA ALLA RELAZIONE CANE-UOMO clicca qui per leggere l’abstract completo
.

Dott. Giacomo Riggio, Medico Veterinario esperto in comportamento , ricercatore in ambito Scientifico Roma, Italia
THE WAY YOU MAKE ME FEEL….IL LEGAME DI ATTACCAMENTO NELLA VITA CON IL NOSTRO CANE clicca qui per leggere l’abstract completo
.

Dott. Paolo Mongillo, Università degli Studi di Padova, Italia
I CANI E LE LEGGI DELLA FISICA clicca qui per leggere l’abstract completo

Dott.ssa Sarah Marshal Pescini, Domestication Lab & Wolf Science Center, Konrad Lorenz Institute of Ethology, University of Veterinary Medicine Vienna
STUDIO DELLA COOPERAZIONE NEL CANE clicca qui per leggere l’abstract completo

Dott.ssa Ludovica Pierantoni, Medico Veterinario esperto in Comportamento, Italia
TITOLO IN ARRIVO
.

Dott.ssa Stefania Traini, Psicologa-psicoterapeuta ed educatore cinofilo, Presidente dell’Associazione Pet Levrieri,
LA TEORIA POLIVAGALE APPLICATA ALLA RELAZIONE CANE-UOMOclicca qui per leggere l’abstract completo

Dott.ssa Stefania Uccheddu, Clinica Veterinaria San Marco (Veggiano-PD)
IL LUTTO NEL CANE E NELL’UOMO clicca qui per leggere l’abstract
.

Dott.ssa Barbara Gallicchio, Medico Veterinario Comportamentalista, Italia
LE STRANE VITE DEI CANI OGGI
.
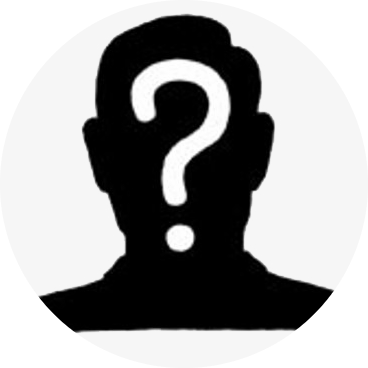
Relatore a sorpesa
NOVITA’! A BREVE SVELEREMO IL NOME DELL’ULTIMO RELATORE DEL CONGRESSO
